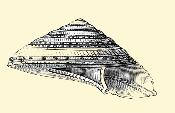
Stefano Gargiullo, commercialista,
professore di Statistica all’Università di Siena,
ci racconta la sua esperienza
di archeologo subacqueo e di editore.
"C•e•r•c•a•r•e
•
n•e•l
•
m•a•r•e
•
i•l
•
s•e•g•n•o
• d•e•l•l'•u•o•m•o"
di M. Gabriella Belisario e Maurizio
Calò
 ..................... ..................... 
Sepolti nelle acque del Mediterraneo giacciono
innumerevoli
tesori archeologici ancora legalmente non ben
tutelati,
di cui l’anfora è il testimonial
più eccellente
Verdi diceva che la musica bisogna averla in corpo.
Tutto bisogna averlo in corpo. La poesia, la letteratura, la fisica, la
chimica, l’amore, tutto; aver dentro una cosa non vuol dire solo amarla,
vuol dire conoscerla da sempre. Nelson odiava il mare... lo vomitava...
e non c’è stato marinaio più marinaio di lui” (Vittorio G.
Rossi, Maestrale, 1976, Mondadori).
Anche Stefano Gargiullo, dottore commercialista,
professore di Statistica aziendale e industriale all’Università
di Siena, ha il mare dentro, una passione che ha dato un’impronta profonda
alla sua vita, ai suoi studi, alle sue scoperte, alle sue letture. Con
il mare e per il mare è diventato editore fondando l’IRECO, l’Istituto
di Ricerche Ecologiche ed Economiche che, tra l’altro, pubblica i suoi
libri. E mentre lo intervistiamo cerchiamo di capire perché l’acqua
sia il secondo elemento naturale di questo solido professionista che come
un vero uomo di mare è di poche parole e riesce a trasmettere quella
pacatezza che sembra conservare in ogni circostanza, sia essa una burrasca
o un amico sub in difficoltà: “Quando avevo sei anni mio padre mi
portò per la prima volta sott’acqua con la maschera. Andavamo a
zonzo in apnea lungo le coste laziali, poi cominciammo a sondare le coste
dell’Argentario per arrivare a Gian-nutri e a Ponza. Da allora non ho smesso
mai. La visione del mondo sottomarino mi ha conquistato per sempre: questa
realtà capovolta, gli scogli vellutati di alghe brune, fasciati
di organismi vibranti, le diverse altimetrie del fondale, valli, foreste,
montagne improvvise e l’acqua piena di vita, di pesci che ti appaiono all’improvviso
prima di fuggire con una rapida virata. Con il fondo ora gremito di ricci,
ora come un letto di sabbia un po’ opaco e polveroso. Fra le rocce forate
dai balani e quelle rese ruvide dalle chiocciole di mare, ogni tanto un
collo d’anfora, un frammento di dolium, un’ancora, colonne di marmo, il
fasciame di una nave e poi un relitto, a volte adagiato, a volte sommerso
sotto la sabbia. Un segno, il segno dell’uomo riposto chissà da
quanto tempo laggiù per sempre”. Una vita di esplorazioni, di viaggi
e di immersioni. Stefano Gargiullo prosegue: “Il mare non invecchia, si
rinnova continuamente, non c’è storia sul mare, non c’è traccia,
non c’è solco di ruota o incisione del ferro. Nel mare l’uomo si
immerge, ma l’acqua si richiude sopra. Il mare prende, nasconde, ripara,
conserva, solo nel profondo dei suoi abissi perché lassù,
sulla superficie, tutto è ogni giorno completamente nuovo. Anche
Alessandro Magno provò l’impulso di scendere sott’acqua e si fece
costruire una campana di vetro per immergersi per pochi metri.
A venti metri di profondità tutto è
omogeneamente grigio o blu e ti chiedi perché alcuni pesci o alcuni
coralli siano così colorati quando laggiù le gamme cromatiche
non sono percepibili. Da quella prospettiva diversa, senza gravità,
si é andato delineando, per me, un altro mondo vastissimo, punteggiato
da testimonianze che il mare conserva e di cui la storia ha bisogno.
Notai che le cose conservate nel mare erano talmente
numerose e ricche da costituire un enorme tesoro attingibile da chiunque.
L’analisi dei relitti e dei manufatti conservati nelle profondità
marine serve a ripensare le abitudini e la vita dei popoli che navigarono
nel Mediterraneo. Da un modello di anfora e dal suo contenuto possiamo
ricostruire il luogo di produzione e la destinazione, la rotta della nave.
Ma perché tutto questo avvenga bisogna avere “l’anagrafico” del
ritrovamento, cioè il luogo, la profondità, il contesto.
Uno scavo condotto male o, peggio, un asporto, cancella questa identità.
L’archeologia marina avrebbe bisogno di un intervento normativo perché
ci troviamo in assenza di leggi specifiche”.
 Dunque
l’uomo di legge prende il sopravvento sull’uomo di scienza e di cultura?
C’è un vuoto legislativo che espone le risorse sommerse dell’Italia
e del Mediterraneo ad essere depredate? Dunque
l’uomo di legge prende il sopravvento sull’uomo di scienza e di cultura?
C’è un vuoto legislativo che espone le risorse sommerse dell’Italia
e del Mediterraneo ad essere depredate?
La legge ancora in vigore è la 1089 del
1/6/39 sulla scoperta fortuita dei tesori ed è l’unica normativa
vigente. Certo non è possibile, attraverso di essa, né salvaguardare
né tutelare adeguatamente i nostri beni sommersi. Dopo un periodo
non breve, in cui le scoperte continue di reperti e relitti dovute a sub
dilettanti avevano colto impreparati gli archeologi “terrestri”, oggi è
stato creato un apposito “Servizio Tecnico dell’Archeologia Subacquea”
(STAS), presso il Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali che, con mezzi
ancora limitati, sta effettuando importanti interventi e coordinando l’attività
delle forze di Stato interessate.
Per quanto riguarda la ricerca in alti fondali,
è stata sottoscritta il 14 maggio 1998 una convenzione tra il Ministero
dei Beni culturali e il Ministero della Difesa: la Marina Militare mette
a disposizione navi, tecnologie ed esperienza (dragamine, minisommergibili,
ecc.) per avviare una campagna quinquennale di ricerche. Forse le recenti
incursioni degli americani nel mare nostrum hanno convinto i politici dell’importanza
della tutela e della ricerca dell’enorme patrimonio
sommerso.
 Dopo
tante esplorazioni, lei ha pubblicato un atlante archeologico dei mari
d’Italia dove, seguendo le coste d’Italia, sono state raccolte e coordinate
non solo le sue esperienze ma anche tutte le segnalazioni di relitti provenienti
dagli appassionati e dai dilettanti. Un lavoro così completo e interessante,
può costituire un riferimento anche per i ricercatori senza scrupoli? Dopo
tante esplorazioni, lei ha pubblicato un atlante archeologico dei mari
d’Italia dove, seguendo le coste d’Italia, sono state raccolte e coordinate
non solo le sue esperienze ma anche tutte le segnalazioni di relitti provenienti
dagli appassionati e dai dilettanti. Un lavoro così completo e interessante,
può costituire un riferimento anche per i ricercatori senza scrupoli?
Questo atlante è una sfida che abbiamo
lanciato a tutti gli appassionati del mare perché intendiamo sollecitare
la più ampia collaborazione delle Soprintendenze affinché
non solo si provveda ad una più estesa e severa legislazione, ma
anche ad una puntuale opera di vigilanza, tutta da organizzare. E comunque
la conoscenza dei siti sommersi può essere importante sia per la
tutela che per la salvaguardia dell’immenso patrimonio archeologico subacqueo.
D’altronde le profondità marine cominciano ad essere una terra di
nessuno e di conquista che comincia a far gola alle grandi imprese che
fanno del recupero dei relitti un business.
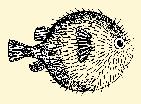 Questo
vale anche per il mare nostrum oltre che per gli oceani? Questo
vale anche per il mare nostrum oltre che per gli oceani?
Sicuramente, anzi l’utilizzazione di mezzi di
ricerca subacquea in profondità, piccoli batiscafi con ecoscandagli,
ha consentito negli ultimi anni la scoperta di reperti inimmaginabili nei
fondali del Mediter-raneo.
Sono recenti le stupende immagini apparse nel
corso delle prospezioni ordinate dalla magistratura sul relitto dell’aereo
di Ustica. Dalle pur poche foto delle quali è stata consentita la
pubblicazione, e pur nell’assai ristretto ambito territoriale nel quale
sono state effettuate le indagini, si sono potuti riconoscere ben tre relitti
di antichi naufragi, due risalenti ad epoca romana ed uno medioevale. Questa
esperienza ha insegnato che in un qualsiasi punto del pagliaio si voglia
guardare, si possono trovare non uno, ma tre aghi!
 Esiste
una stima del numero dei tesori inabissati? Esiste
una stima del numero dei tesori inabissati?
Alcuni calcoli assai approssimativi hanno stimato
in “decine di migliaia” i relitti di navi da trasporto o da guerra, perfettamente
conservati, giacenti su fondali profondi nel Mediterraneo, molti dei quali
ricchi di tesori non solo archeologici.
Queste cifre hanno attirato l’attenzione di alcune
imprese americane specializzatesi, negli ultimi anni, nella ricerca e recupero
di relitti e tesori sommersi, che spesso hanno ottenuto risultati clamorosi
con il rinvenimento di carichi di oro e preziosi, specialmente nella zona
del Mar dei Caraibi.
Se queste organizzazioni, che hanno necessità
di operare continuamente e con risultati positivi per ammortizzare gli
elevatissimi costi di manutenzione e di ammodernamento di tecnologie raffinate,
si orientassero nelle acque internazionali del Mediterraneo, probabilmente
troverebbero del tutto impreparati gli organismi di tutela del nostro patrimonio
archeologico. Infatti, non esiste, al momento, un organismo sovranazionale
in grado di varare una legislazione comune ed efficace per quanto concerne
le acque internazionali del Mediterraneo ed ancor meno di farla poi rispettare.
In epoca antica il trasporto via mare era quello
privilegiato dalle regioni che si affacciavano sul bacino del Mediterraneo:
esso, infatti, si presentava prevalentemente calmo e con una buona visibilità
per gran parte dell’anno, si poteva bordeggiare navigando a vista. Inoltre,
numerosi erano i ripari o approdi in caso di necessità, eppure le
tempeste non hanno risparmiato la navigazione in tutte le epoche, da quella
fenicia, greca e romana fino ai nostri giorni.
 Torniamo
a parlare di tesori e di rinvenimenti straordinari. Ce ne è stato
uno che fece parlare di sé in modo particolare? Torniamo
a parlare di tesori e di rinvenimenti straordinari. Ce ne è stato
uno che fece parlare di sé in modo particolare?
Recentemente, tra Ventotene e l’Isola di Santo
Stefano, sopra un fondale sabbioso chiamato Secca delle Grottelle, fu rinvenuto
quello che possiamo definire lo yacht di Augusto. Per caso, nel corso di
un normale controllo, la Guardia di Finanza fermò un’imbarcazione
tedesca a bordo della quale c’erano delle anfore romane di tipo Dressel
1,B (dal nome dello studioso che per primo catalogò questi contenitori)
in perfetto stato di conservazione. Era l’estate dell’83 e cominciarono
le ricerche. Il relitto giaceva a 42 metri di profondità, era già
stato purtroppo parzialmente saccheggiato ma tutto quello che rimaneva
era ancora straordinario. 400 reperti di bronzo, avorio, osso, ceramica
e legno hanno permesso di ipotizzare che questa nave, dalle rifiniture
di lusso, fosse stata costruita per scopi di rappresentanza, per trasportare
comodamente personaggi e notabili. Tra l’altro è stata rinvenuta
un’ara sacrificale, un catino di marmo dove veniva tenuto acceso il fuoco
sacro e un’ancora di tipo “ammiragliato”. Questa nave risale al periodo
in cui Augusto era stato costretto a confinare la figlia, con un’apposita
legge, la Lex Julia, a Ventotene a causa della sua discussa condotta morale,
esilio forse malinconico, ma dorato, consumato nella splendida villa di
Punta Eolo e comunque corredato da tutte le comodità.
Era il primo secolo dopo Cristo e la presenza
di Giulia nell’arcipelago pontino rese comunque Ventotene un centro di
potere politico e culturale, intensificando gli scambi e le rotte con la
terraferma. Così solo tra Ventotene e l’Isola di Santo Stefano,
quindi in un braccio di mare di poche miglia, sono stati trovati ben due
relitti entrambi molto interessanti. Ma per quanto riguarda lo yacht di
Augusto c’è di più: la testimonianza palpabile della vita,
ovvero il tentativo di ricostruirsi una vita normale, anche lontano dalla
Città Eterna. Si stavano trasportando, al momento del naufragio,
avvenuto presumibilmente a causa di un incendio di cui si trovano ancora
le tracce sotto il mare, le piccole e grandi comodità della Roma
Imperiale: alcuni stili per la scrittura in avorio, ancora chiusi nel loro
astuccio di legno, e molti altri sfusi, bulini per incidere e graffire,
piccole tazze, manici di avorio, residui di vasellame pregiato, sandaletti
di legno e piccole sculture, testine in osso magistralmente incise, placche
di bronzo finemente lavorate, elementi decorativi del klinai (letti-divani)
e di altri mobili presumibilmente di fattura siriana. E poi le anfore,
alcune ancora sigillate, piene di nocciole, spezie, graspi di uva e garum,
la salsa di pesce cara ai Romani. Anche se ci sono stati, dal ’50 ad oggi,
rinvenimenti più clamorosi, navi onerarie affondate a pieno carico,
che ci raccontano molto sui commerci dei romani con Spagna, Grecia e Asia
Minore, solo in questo caso si è sollevato un velo sugli aspetti
più segreti dell’esilio, istituzione molto applicata in epoca imperiale,
come testimonia l’enorme quantità di penne pronte a scrivere chissà
quali segreti, accuse, delazioni o memorie nel triste isolamento di Ventotene.
 Dicevamo
di navi commerciali imponenti rinvenute intatte in Italia. Dove? Dicevamo
di navi commerciali imponenti rinvenute intatte in Italia. Dove?
Parliamo subito del relitto di Albenga, un ritrovamento
cardine, che ha costituito la base di una nuova disciplina: l’archeologia
marina. È la più grande nave oneraria di epoca repubblicana
mai conosciuta: lunga 40 metri, larga 10, con un carico di 11.000 anfore
vinarie disposte fino a 9 strati. Potremmo dire oggi, con linguaggio moderno,
una nave cisterna. 1300 anfore di questo carico, perfettamente conservate
e recuperate, sono visibili al Museo Navale Romano di Albenga. Era il 1950:
i pescatori del luogo, dicevano che a circa un chilometro e mezzo dalla
foce del fiume Centra, esistevano i resti di una nave romana enorme, quasi
leggendaria. Il professor Lamboglia si accinse a cominciare una vera e
propria campagna di scavo. È chiaro che i mezzi furono improvvisati
e che i metodi di quel primo intervento fecero molto discutere, ma questa
nuova branca dell’archeologia terrestre stava muovendo i primi passi. Seguirono
anni di ricerche, di rinvenimenti e di inventari. La nave, all’incirca
della prima metà del I° secolo a.C., era colata a picco molto
rapidamente a causa del gran peso, ma senza riportare gravi danni alla
struttura. Trasportava vino, grano e nocciole, presumibilmente dalla terra
di Spagna, e il suo equipaggio era armato perché furono rinvenuti
anche elmi di bronzo.
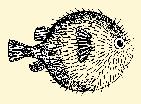 Soprattutto
allora, era importante distribuire il peso e organizzare bene le operazioni
di carico? Soprattutto
allora, era importante distribuire il peso e organizzare bene le operazioni
di carico?
Innanzitutto bisognava garantire la stabilità
dell’imbarcazione e delle merci durante il viaggio, anche in condizioni
di mare difficili, dal momento che un carico mal disposto poteva rendere
complicato se non impossibile governare la nave.
Bisognava curare che i contenitori non si rompessero
e ottimizzare gli spazi, per ragioni economiche, trasportando la maggiore
quantità possibile di prodotto.
Normalmente i generi più pesanti venivano
posti nella parte bassa della stiva, al centro della nave, mentre la ceramica
e le merci leggere erano messe al di sopra o tra un contenitore e l’altro.
Un esempio significativo è fornito dal relitto rinvenuto a La Tradelière,
dove sacchi di nocciole erano posti tra le anfore e i vetri, i quali erano
protetti da scatole.
Le anfore erano disposte generalmente su più
livelli, 3 o 4 al massimo (la presenza di nove piani di anfore rinvenute
nel relitto di Albenga deve essere considerata un’eccezione); quelle del
piano inferiore erano fissate in uno strato di sabbia o di ghiaia, gli
altri livelli erano disposti a scacchiera, con un contenitore ogni tre
oppure ogni quattro colli di anfore dello strato inferiore. Lo spazio che
si veniva a formare tra le spalle dei vasi era colmato con l’inserimento
di paglia, giunchi o piccoli rami che ammortizzavano eventuali urti.
 Ci
sono misteri, enigmi insoluti legati a questi ritrovamenti? Ci
sono misteri, enigmi insoluti legati a questi ritrovamenti?
Potremmo parlare del segreto del dolium, questo
enorme contenitore di terracotta a forma globulare che aveva capacità
da 1200 a 3000 litri e che poteva trasportare sia olio o vino, che sementi
o legumi. Per capire quanto fossero grandi bisogna pensare che quelli oblunghi
contengono l’equivalente di 40 anfore, quelli sferici arrivano a 100-110
anfore.
Alti 2 metri e rivestiti di pece erano, come dire, il cuore del carico.
Ebbene, ogni tanto, nel mare, vicino alle isole e alle coste, si trovano
dolia isolati, ma integri, come se fossero stati perduti o posati in particolari
condizioni che noi oggi non riusciamo a ricostruire. Questo è il
caso, per esempio, del dolium di Punta Lividonia all’Argentario, recuperato
nel 1985. Poi ci sono veri e propri tesori, come quello che capitò
nella rete di un pescatore nel Golfo di Baratti. Era un’anfora d’argento
che aveva impressi sulla superficie ben 132 medaglioni: satiri, menadi
danzanti, baccanti, eroi greci e segni zodiacali. La fattura finissima,
di origine mediorientale, il valore indubbio anche nell’antichità,
possono portare a supporre che facesse parte dell’ampio bottino di una
nave crociata, reduce da chissà quali saccheggi e a sua volta naufragata
nello specchio di mare davanti a Populonia. Luogo fecondo perché
ci ha restituito, nel 1832, il famoso Apollo di Piombino e, recentemente,
una bella statua di marmo del III sec. a.C.
 Si
può considerare “un tesoro” una semplice anfora, anche se non in
materiale prezioso? Si
può considerare “un tesoro” una semplice anfora, anche se non in
materiale prezioso?
Questi contenitori sono un po’ l’unità
di misura dell’archeologia marina. La posizione di un relitto antico è
segnalata dalla presenza intorno, sopra e sotto di materiali archeologici,
tra i quali le anfore hanno un ruolo preponderante. La mappa dei ritrovamenti
è uno strumento importante per ricostruire le rotte e i luoghi dello
scambio. Sappiamo che i traffici erano frequenti soprattutto nella parte
occidentale del Mediter-raneo e ciò è dovuto principalmente
alle esportazioni di vino italico nel II-I sec. a.C., all’esportazione
di olio spagnolo dal I al III sec. d.C. e alle esportazioni africane dal
III sec. fino ad età tardoantica. Quanto al vino, bevanda principe
della dieta dei nostri antenati in epoca imperiale, cominciò ad
essere distribuito gratuitamente alla plebe. Certo non era il forte Cecubo
o l’abboccato Falerno o il vino resinato greco, ma a Roma, al tempo di
Augusto, se ne consumava fino a un milione e mezzo di ettolitri l’anno.
Furono necessarie grandi quantità di vino a buon mercato che determinarono
un’inversione di tendenza del suo commercio, con conseguenti importazioni
dalla Spagna e dalla Gallia. Le dimensioni e la tipologia delle imbarcazioni
utilizzate per il trasporto marino sono state ormai catalogate in tre tipi:
le navi più piccole, con un carico inferiore alle 75 tonnellate
corrispondenti a 1500 anfore, costitui-vano il tipo più comune;
quelle medie, con un carico tra le 75 e le 200 tonnellate, corrispondenti
a 2000-3000 anfore, erano le “navette” del I e III sec. d.C. Un tipo più
grande e in numero limitato poteva, infine, contenere oltre le 250 tonnellate
(più di 6000 anfore): era considerato un trasporto “pesante” e,
spesso, veniva scortato.
 Dunque
l’archeologia marina ci presenta un’intensa produzione manufattiera di
recipienti in ceramica, anzi questi sembrano la base della possibilità
di scambio di merci tra i popoli. Come venivano fabbricate e quanti tipi
se ne conoscono? Dunque
l’archeologia marina ci presenta un’intensa produzione manufattiera di
recipienti in ceramica, anzi questi sembrano la base della possibilità
di scambio di merci tra i popoli. Come venivano fabbricate e quanti tipi
se ne conoscono?
Nonostante le numerose varianti assunte nei secoli,
la forma base dell’anfora rimase costante, in quanto legata alla sua funzionalità.
Il collo era allungato e terminava in un orlo ingrossato che permetteva
la chiusura ermetica del vaso ed evitava la fuoriuscita del contenuto.
I primi tappi furono pigne compresse, poi con
sughero e argilla si creò l’anforisco, che veniva sigillato con
resina, pozzolana o calce. Il fondo era generalmente a punta e costituiva,
insieme alle anse, un ulteriore punto di presa durante le operazioni di
spostamento e svuotamento; esso, inoltre, permetteva di impilare facilmente
i contenitori durante il trasporto. Infine le pareti dell’anfora erano
notevolmente spesse così da non consentire facili danni e rotture.
Le varie parti che componevano l’anfora erano
lavorate separatamente ed unite insieme prima della cottura che avveniva
in un apposito forno. Il corpo era realizzato con il tornio, mentre le
anse venivano eseguite a mano e attaccate al vaso ormai completato.
A differenziare ulteriormente questo popolare
comune manufatto, c’erano le etichette del tempo. Iscrizioni graffite,
le bollature con punzoni di legno garantivano le qualità della merce
(data di scadenza ante litteram) esprimendo l’anno di confezione, il nome
della città di provenienza, il fabbricante, il peso vuoto del recipiente,
l’unità ponderale usata e il nome del prodotto. E poi, nel caso
di famiglie proprietarie di ampi territori, la zona di produzione.
Insomma queste testimonianze di ceramica ci riportano
l’impressione di un commercio evoluto con “bolle di accompagno” incise
o dipinte sui contenitori: a volte si indicava anche il porto d’imbarco
e la data consolare.
Le anfore che ritroviamo nel Mediterraneo non
sono solo quelle della civiltà romana, le famose Dressel , dal nome
dello studioso di anforologia che, per primo, nell’800, ne individuò
ben 45 tipi. Ci sono bellissimi contenitori fenici, anfore greche, etrusche,
galliche, spagnole, portoghesi, africane ed egiziane. Segni vivi di appartenenza
ad un determinato popolo. E noi conoscendo forme fogge e dimensioni, con
un’occhiata possiamo rintracciare la civiltà che ha depositato il
suo prezioso carico in fondo al mare.
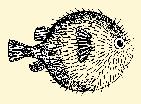 Ci
sono ancora speranze di clamorose scoperte archeologiche subacquee? Ci
sono ancora speranze di clamorose scoperte archeologiche subacquee?
Solo recentemente la tecnologia ha permesso all’uomo
di avere i mezzi per esplorare il fondo marino. L’archeologia subacquea
è quindi, tutto sommato, ancora agli inizi, anche se il progresso
delle scienze sta mettendo a disposizione strumenti sempre più efficaci
per questo tipo di ricerche ed il numero degli appassionati aumenta sempre
di più. L’esperienza delle indagini di Ustica, con ben tre relitti
entro un raggio piccolissimo di indagine, conferma che ci sono in fondo
al mare molti più reperti archeologici che non sulla terra ferma.
L’archeologia subacquea contiene quindi, più che la speranza, una
vera e propria promessa di scoperte clamorose, molte delle quali alla portata
della maggior parte dei subacquei, come dimostra lo yacht di Augusto rinvenuto
a soli 42 metri di profondità e a poche miglia dalla costa di due
isole. Del resto, lo sviluppo della sensibilità per gli aspetti
ecologici e ambientali e l’abbandono sempre più marcato della pesca
subacquea, portano ad incrementare un “turismo” subacqueo dal quale l’archeologia
ha tutto da guadagnare, se il legislatore interverrà rapidamente.
 
L•a
•
n•a•v•i•g•a•z•i•o•n•e
a •
v•e•l•a
L’utilizzazione della forza del vento
per far navigare una barca,
liberando l’uomo dallo
sforzo muscolare del remo,
risale a circa 5.000 anni fa.
Documentazione certa di questo tentativo esiste
in numerosi casi per l’antico Egitto, dove pitture murali e reperti, fin
dall’epoca delle prime dinastie, testimoniano delle avanzate capacità
di navigazione di quel popolo. In epoca più tarda - all’incirca
2.000 o 1.500 anni prima di Cristo - splendidi ed elegantissimi modelli
di imbarcazione ci informano in maniera dettagliata sulle loro tipologie
e sulle tecniche costruttive. La navigazione degli antichi egizi era essenzialmente
di tipo fluviale: il Nilo, che rappresentava per questo popolo la sopravvivenza
e, anzi, la prospe- rità, era anche una comoda ed ampiamente utilizzata
via di comunicazione percorsa per centinaia di chilometri fino al mare.
Per gli antichi Egizi, come anche per tutti gli
altri popoli dell’antichità, l’unico tipo di vela conosciuto ed
utilizzato era la vela quadra: si trattava di un grande telo di stoffa,
di forma all’incirca quadrata/rettangolare, sostenuto verticalmente da
un albero e disteso da aste perpendicolari, che in questo modo riceve la
pressione del vento, la quale viene utilizzata come forza propulsiva.
Ovviamente, una velatura di questo tipo può
essere adoperata soltanto quando il vento spira, non troppo violentemente,
nella direzione in cui si vuole andare, mentre è inutilizzabile
in tutti gli altri casi.
Nonostante ciò, fù servendosi di
imbarcazioni così equipaggiate che i Greci e i Fenici iniziarono
i loro commerci, conquistando il Mediterraneo e che i Romani - un popolo
inizialmente tutt’altro che marinaro, e che molto seppe imparare dai propri
tradizionali nemici, i Cartaginesi - giunsero a padroneggiare le rotte
di tutto il Mediterraneo, tanto da farne il mare nostrum.
Tuttavia, la necessità di trovare un mezzo
che consentisse di sfruttare più ampiamente la forza del vento,
anche con andature diverse da quelle di poppa, portò ad una innovazione
fondamentale.
Si tratta dell’adozione della cosiddetta “vela
latina”, cioè di una vela di forma quasi triangolare, sostenuta
da un lungo palo (denominato “antenna”) a sua volta incardinato alla testa
dell’albero, che può formare un angolo variabile con la direzione
del vento, consentendo quindi la navigazione al traverso.
Le origini di questo tipo di vela si collocano
in estremo Oriente, probabil- mente già quasi 4.000 anni fa, ma
essa fu conosciuta e diffusa nel Mediter- raneo soltanto molti secoli dopo,
nel VII sec.d.C., perché adottata dagli Arabi.
Nei secoli intorno al Mille, le imbarcazioni
si dividono abbastanza distintamente in due categorie: l’una, con vela
quadra, scafo di forma piena e con castelli di prora e poppa, derivava
dalla nave da carico dei Romani, e dette origine ai velieri moderni (fregata
e galeone); l’altra, un tipo di nave veloce, più affusolata e leggera,
armata con molti remi e un albero con vela latina non ebbe seguito e si
estinse con la galea.
Col progredire delle tecniche di navigazione,
la vela latina fu impiegata spesso insieme alla vela quadra, dando origine
a velature miste, che raggiunsero anche una notevole complessità.
Infatti, l’albero unico che aveva dominato per
millenni la navigazione a vela fu affiancato sin dai primi secoli dell’era
cristiana con un piccolo secondo albero, poi sviluppatosi completamente
solo nel XIV sec. Poco più tardi, nel XV secolo, si impose per la
navigazione d’alto mare l’imbarcazione a tre alberi, che utilizzava contemporaneamente,
in diverse posizioni, sia le vele quadre che le vele latine.
Questi scafi da alto mare del XV sec., benché
muniti di tre alberi, avevano comunque delle dimensioni piuttosto modeste:
basti pensare che la caravella “Santa Maria”, la nave ammiraglia della
piccola flotta con la quale Colombo varcò per la prima volta l’Atlantico,
era lunga 26 metri, mentre la “Nina” e la “Pinta” erano ancora più
piccole. Hudson, nel 1609, esplorò la grande baia americana che
porta il suo nome con una caravella di soli 18 metri di lunghezza.
In seguito, l’attività di esplorazione,
ma soprattutto lo svilupparsi dei commerci, diedero un impulso fortissimo
alle costruzioni navali perseguendo sia l’aumento delle dimensioni che
quello della velocità.
Pur con una evoluzione tecnica e costruttiva
enorme, tuttavia i principi fondamentali della navigazione a vela erano
ormai stati sanciti: la vela quadra fu impiegata ancora gloriosamente ed
a lungo insieme alla vela latina nei bastimenti successivi, fino all’apogeo
del clipper ottocentesco, il veloce scafo affusolato nato nel segno della
velocità, che poteva esporre fino a 3.000 metri quadri di velatura.
Con la rivoluzione industriale cominciò
il declino del veliero, quanto meno nell’ambito mercantile, risultando
più conveniente affidarsi alla propulsione a vapore. Con l’avvento
di questo secolo i grandi velieri praticamente sono scomparsi, anche per
la comparsa dell’aeroplano, mentre sopravvivono tuttora le piccole imbarcazioni
a vela da lavoro.
Oggi meravigliose imbarcazioni a vela solcano
ancora una volta i mari: la navigazione sportiva e da diporto ha dato nuova
vita ad un’arte antichis- sima introducendo, intorno ai primi anni ‘60,
gli scafi in vetroresina.
Con il supporto di tecnologie costruttive, materiali
e progettazioni sofisticatissimi, le moderne sfidanti della Coppa America
e di tante altre prestigiose regate intorno al mondo riutilizzano e reinterpretano
abilità e conoscenze consolidate nei secoli.
Gira pagina

INDIETRO
|

AVANTI
|
|

